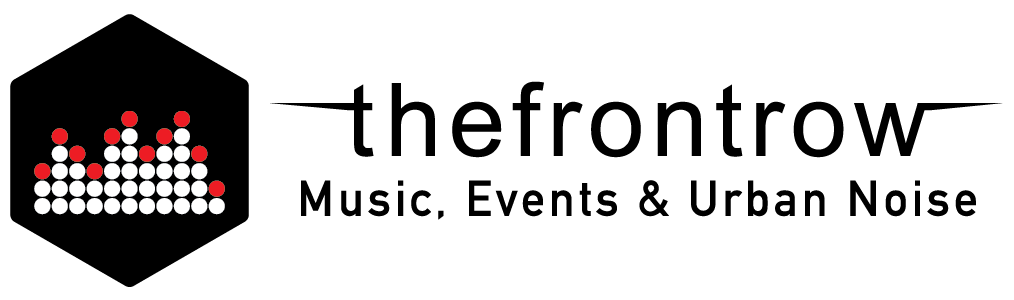Sono passati quasi quarant’anni da quando nelle radio si iniziò ad ascoltare un brano elettronico e mitteleuropeo che aveva come ritornello “a Berlino che giorno è”. Dietro quelle parole quasi ermetiche si celava un giovane artista milanese chiamato Garbo. Per sua scelta non ha mai voluto cavalcare quel successo, almeno dal punto di vista economico. Il suo desiderio era quello di diventare famoso, ma senza scendere a compromessi e soprattutto senza rincorrere il dio denaro. Oggi, sebbene abbia regalato moltissimo alla musica italiana in termini di sperimentazione, prosegue proponendo piccoli show case inframmezzati a tante parole. Musica e chiacchiere attorno ad una figura sicuramente interessante, dal punto di vista artistico ed umano. Nelle scorse settimane Garbo è stato invitato da Le Baladin di Piozzo (Cuneo) per una serata celebrativa. Insieme con la sua fida spalla Luca Urbani ha regalato un paio d’ore assolutamente piacevoli. Ecco cosa ha raccontato.
Garbo che tipo di artista ti definiresti?
«Mi sento un musicista svincolato dall’omologazione, che ha creato i suoi brani cercando di non somigliare a qualcos’altro».
Come è iniziata la tua carriera?
«Iniziai a metà anni ’70 a comporre la mia prima musica. Per la verità erano i primi tentativi di farlo e non mi sentivo nemmeno molto incoraggiato. Mi ricordo che una mattina di primavera, andai da mia madre che stava rifacendo i letti. Imbracciai la mia chitarra acustica e le cantai “A Berlino va bene” (il suo primo successo, ndr). Lei mi ascoltò e alla mia richiesta di sapere cosa ne pensassi, mi disse: “interessante”. Era del tutto evidente che sulla sua faccia era stampata l’espressione tipica di chi stava pensando: ma che cos’è sta roba?».
Eppure quel brano divenne un successo…
«Fu un fulmine a ciel sereno. Ero un ragazzo intelligente, ma con i piedi per terra, un po’ come tutti i bambini cresciuto con un’educazione rurale. L’ultimo dei miei problemi era quello di fare soldi, anche se fin da piccolo ho cullato l’ambizione di diventare famoso. Certo speravo che la musica potesse portarmi al successo, ma mai più avrei pensato che potesse diventare un lavoro. Era semplicemente una passione. Tutto rimase circoscritto ai sogni, fino a quando un discografico mi consigliò di provare ad incidere il pezzo. Io risposi di si, senza sapere bene cosa stesse significando quel passo. Di colpo mi trovai negli uffici della Emi, dove sottoscrissi un contratto. Come d’incanto mi ritrovai in televisione faccia a faccia con Pippo Baudo e Raffaella Carrà».
Cosa pensasti in quel momento?
«Non mi sentivo nazional popolare ed in quel contesto ero davvero un pesce fuor d’acqua. Proseguii solo perché già sapevo che non sarei mai sceso a compromessi e avrei fatto soltanto ciò che ritenessi più giusto. Non ho mai perso la testa, ma il successo quello sì».
Davvero non ti attiravano i soldi e la fama?
«Ho fatto Sanremo, il Festivalbar ma alla fine mi sono stufato. E questo senso di noia per un mondo tanto lontano, mi ha tenuto alla larga da trasmissioni quali “I migliori anni della nostra vita” , ma anche dai talent show, che pure hanno attirato altri miei colleghi. Penso a Morgan o a Manuel Agnelli. Mi sono chiesto più volte perché abbiano accettato il ruolo di giudice e l’unica risposta che sono riuscito a trovare è stata: “grano pesante”. Oggi non si vendono più dischi e ogni cosa può avere un prezzo. Tengo a sottolineare che parlo di loro perché sono amici. Non mi sento di criticarli, anzi li capisco, ma io non avrei mai potuto fare la stessa cosa».
Sei stato uno dei precursori della musica elettronica in Italia. Con chi hai collaborato in quel periodo?
«Eravamo un manipolo di persone che si frequentavano con una certa assiduità. Ricordo Enrico Ruggeri con i Decibel, poi c’erano i Krisma e Faust’ò. C’era anche una scena fiorentina che era ai tempi sconosciuta. Molti mi citano come il primo esponente della musica alternativa ad aver “scoperchiato i tombini” della celebrità, firmando per una major e aprendo la strada a molti altri artisti underground. Con il senno di poi possiamo dire che quel manipolo di sperimentatori è rimasto tale, senza mai raggiungere picchi di celebrità».
Eri in contatto con artisti stranieri?
«Certamente ho avuto modo di confrontarmi con David Bowie e David Silvyan. Entrambi hanno sempre tenuto a sottolineare come la strada della sperimentazione fosse la più difficile. Ricordo che Bowie ha sofferto e lottato moltissimo. All’inizio era poco conosciuto e sottovalutato. Ha impiegato 10 anni per emergere».
Cosa pensi della musica nostrana?
«In Italia ci sono molti rocker che riempiono gli stadi, che fanno da sempre la stessa musica. Io francamente mi annoierei, anche se rimango consapevole che queste mie scelte sono controproducenti a livello commerciale».
Sarai ricordato per il tuo abbigliamento essenziale e poco appariscente…
«Ho sempre pensato che il nero fosse un modo per annullare la mia fisicità e far emergere la personalità musicale. In realtà una piccola concessione me la sono sempre regalata: mi truccavo. Ma la mia non era una questione artistica: io con quel trucco io cuccavo moltissime donne. Ho apprezzato Bowie per aver puntato sul suo look, ma credo che questa scelta fosse più consona alla scena del rock ‘n roll americano o inglese. Fondamentalmente mi sento molto più vicino agli attori francesi, che non hanno abiti di scena e recitano così come sono».
Sei stato uno sperimentatore anche per ciò che concerne i testi…
«Storicamente i testi appartenevano ai cantautori, che raccontavano sostanzialmente delle storie. Tra le mie sperimentazioni c’era quella di scrivere brani fotografici senza un contesto storico, quasi come fossero poesie. Il mio è sempre stato un concetto molto foscoliano: usare le mie canzoni per non morire mai».
Quanto ti hanno influenzato le donne?
«Moltissimo. Non ho mai fatto canzoni d’amore, ma i miei brani servivano per comunicare con il gentil sesso. In fondo mia madre è stato il primo esempio di come fossero importanti. Lo è stato quando le feci ascoltare il mio primo brano, ma ancora di più quando riuscii a superare le sue perplessità e arrivai al successo con i miei dischi».
Ritornando a David Bowie, possiamo dire che avete una “stella” in comune?
Con Robert (il vero nome di Bowie, ndr) abbiamo in comune una Stella nera. 42 anni fa scrissi un brano (“Stella nera”, ndr) che rimase chiuso nel cassetto fino ad oggi. Decisi di pubblicarlo nel 2015 insieme con Luca Urbani nel disco “Fine”. Sei mesi dopo usci “Black Star”, con cui l’artista inglese ha anticipato la sua morte. Inutile sottolineare di come mi sia sentito davvero male a pensare a questa coincidenza».
Intervista a cura di Vincenzo Nicolello